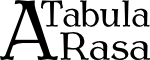Maré Almani
Che cos'è il terrorismo?
Nel maggio del 1898 re Umberto I, preoccupato per le notizie che giungevano da Milano, dove era appena scoppiato uno sciopero generale, affidò al generale Bava Beccaris il compito di reprimere la sommossa. Ai soldati venne dato ordine di sparare a vista, e Bava Beccaris fece aprire il fuoco sulla città con i mortai. Il bilancio fu di 80 morti e 450 feriti. Fiero dell’impresa compiuta, il generale telegrafò al re che Milano era ormai “pacificata”. Il capo del governo, il marchese Di Rudini, fece sopprimere oltre cento giornali di opposizione, le Camere del Lavoro, i circoli socialisti, le Società di Mutuo Soccorso, nonché 70 comitati diocesiani e 2500 comitati parrocchiali. Furono inoltre chiuse le Università di Roma, Napoli, Padova e Bologna e vennero eseguiti migliaia di arresti. Più tardi, i tribunali distribuiranno 1400 anni di carcere. A Bava Beccaris, Umberto I inviò subito un telegramma di felicitazioni e la croce dell’Ordine Militare di Savoia «per i preziosi servigi resi alle istituzioni e alla civiltà». Due anni dopo, il 29 luglio 1900, l’anarchico pratese Gaetano Bresci sollevava re Umberto I dal peso delle proprie responsabilità, uccidendolo a Monza.
Il Re e l’anarchico. Entrambi assassini, con le mani sporche di sangue: è innegabile. Eppure, sono forse equiparabili? Non lo penso. Né penso che le motivazioni e le conseguenze delle loro rispettive azioni si possano considerare alla stessa stregua.
E allora, giacché essi non possono venir uniti in una comune esecrazione, quale dei due si può dire che commise un atto di terrorismo? Il re che fece massacrare la folla, o l’anarchico che sparò al re?
Domandarsi cosa sia il terrorismo è uno di quegli interrogativi che in apparenza è inutile porre perché destinati a una risposta univoca, ma che in realtà — se formulati in modo rigoroso — non mancano di suscitare reazioni sorprendenti. Le risposte infatti sono sempre varie e contraddittorie. «Terrorismo è la violenza di chi combatte lo Stato», diranno alcuni; «terrorismo è la violenza dello Stato», ribatteranno altri; «macché, terrorismo è qualsiasi atto di violenza politica da qualsiasi parte provenga», preciseranno altri ancora. Per non parlare delle dispute che si aprono di fronte alle ulteriori distinzioni che si possono fare al riguardo; ad esempio, il terrorismo è solo la violenza contro le persone o anche quella contro le cose? Deve possedere necessariamente una motivazione d’ordine politico? O si caratterizza solo per il panico che semina?
La molteplicità di significati assegnati a questo termine è sospetta. La sensazione in questo caso non è di trovarsi al cospetto dei soliti equivoci dovuti all’incapacità delle parole di esprimere una realtà la cui complessità trascende i simboli che vorrebbero rappresentarla. L’impressione al contrario è quella di trovarsi di fronte ad un confusionismo interessato, ad una relativizzazione di interpretazioni creata artificialmente con l’intento di svuotare le idee di ogni significato, di neutralizzarne la forza pratica, di banalizzare l’intera questione riducendo a chiacchiericcio ogni riflessione che si potrebbe fare in proposito. Eppure questa parola di dieci lettere avrà pure una sua origine, una sua storia, da cui è possibile ricavare un significato in grado di dissipare, se non tutti, almeno buona parte degli equivoci che oggi il suo uso ingenera. In effetti è così.
La prima definizione che viene assegnata a questo termine dalla gran parte dei dizionari è di carattere storico: «Il governo del Terrore in Francia». Sappiamo quindi con precisione l’origine del vocabolo. Terrorismo è il periodo della Rivoluzione Francese che va dall’aprile 1793 al luglio 1794, quando il Comitato di salute pubblica guidato da Robespierre e Saint-Just ordinò un alto numero di esecuzioni capitali. Il Terrore era quindi rappresentato da quella ghigliottina sotto la cui lama persero la testa migliaia di persone, che si presumeva costituissero una minaccia per la sicurezza del nuovo Stato in formazione. A partire da questa premessa, gli stessi dizionari giungono per estensione a una definizione di terrorismo più generale: «ogni metodo di governo fondato sul terrore».
Ora, questa prima interpretazione del concetto di terrorismo è estremamente chiara. Innanzitutto mette in luce lo stretto legame che intercorre fra terrorismo e Stato. Il terrorismo è nato con lo Stato, è esercitato dallo Stato, è appunto un «metodo di governo» che lo Stato impiega contro i suoi nemici per garantire la propria conservazione. «La ghigliottina — diceva Victor Hugo — è la concrezione della legge». Ed è solo lo Stato a poter promulgare la legge che, lungi dall’essere espressione di quel contratto sociale garante dell’armoniosa convivenza fra gli esseri umani, rappresenta il filo spinato con cui il potere protegge i propri privilegi. Chi osasse oltrepassarlo, dovrà fare i conti con le mani del boia. Comunque, già prima dell’aprile 1793 sul patibolo erano saliti alcuni cosiddetti criminali comuni e anche degli insorti. Checché se ne pensi, la ghigliottina non è affatto un’invenzione di monsieur Guilloton. Nella stessa Francia questo strumento di esecuzioni capitali aveva già una sua tradizione, ma nessuno ancora parlava di Terrore. Solo quando l’autorità dello Stato, in quel momento in mano ai giacobini, si vedrà minacciata dall’ondata rivoluzionaria, solo quando lo Stato dovrà fare i conti non con semplici fuorilegge o insorti isolati, ma con un enorme movimento sociale sul punto di travolgerlo, solo allora la violenza repressiva si chiamerà Terrore.
Ma, oltre alla sua natura istituzionale, esiste un’altra caratteristica che contraddistingue il terrorismo: chiunque ne può rimanere vittima. Durante il periodo del Terrore nella sola Parigi sarebbero avvenute circa 4.000 esecuzioni. Louis Blanc avrebbe ritrovato i documenti di 2750 ghigliottinati, scoprendo che solamente 650 di loro appartenevano a classi agiate. Ciò significa che la macchina statale della ghigliottina non faceva poi tante distinzioni, decapitando chiunque venisse ritenuto scomodo o sospetto. Ad aver perso la testa durante quelle giornate non sono stati solo i nobili, i militari e i preti — come vorrebbe la propaganda più conservatrice e tradizionalista — ma soprattutto semplici artigiani, contadini, poveri. Il terrorismo è tale perché colpisce alla cieca, da cui il sentimento di panico collettivo che esso ispira. L’uso indiscriminato della ghigliottina, sistematizzato dalla semplificazione delle procedure giudiziarie autorizzata dalla legge di Prastile, crea un effetto irreversibile di operazioni fatte in serie, annullando le differenze individuali fra tutti questi decapitati. Questa pratica dell’amalgama ha un significato politico preciso: raggruppando in una stessa seduta persone sospettate di “crimini” di natura o di entità assai differenti, il Terrore mira ad annientare le diversità individuali a vantaggio del consenso popolare, e a distruggere «l’abiezione dell’io personale» (Robespierre), giacché deve esistere una sola entità nella quale fondere gli individui: lo Stato.
Il terrorismo è nato quindi come strumento istituzionale e indiscriminato. Entrambi questi due aspetti riecheggiano anche in espressioni di uso corrente come, ad esempio, «bombardamenti terroristici». Un bombardamento, infatti, non solo avviene nel corso di una guerra condotta fra Stati, ma semina terrore e morte in tutta la popolazione. Lo stesso discorso si potrebbe fare per quanto riguarda il terrorismo psicologico, che viene considerato una «forma intimidatoria o ricattatoria di manipolazione dell’opinione pubblica, attuata soprattutto attraverso i mezzi di comunicazione con l’esagerare i pericoli di certe situazioni o addirittura inventandoli, allo scopo d’indurre le masse a determinati comportamenti sul piano politico, sociale, economico». Si vede bene come solo chi detiene il potere sia in grado di manipolare i grandi mezzi di comunicazione e, attraverso essi, il comportamento delle “masse” al fine di raggiungere i propri scopi.
Dunque, il terrorismo è la violenza cieca dello Stato. L’origine del termine lo dimostra in maniera inequivocabile. Ma il linguaggio non è mai espressione neutra. Lungi dall’essere meramente descrittivo, il linguaggio è anzitutto un codice. Il senso delle parole indica sempre la direzione verso cui sta pendendo la bilancia del dominio. Chi detiene il potere detiene anche il significato delle parole. Ciò spiega come mai con il passare del tempo il concetto di terrorismo abbia assunto un nuovo significato, che se contraddice completamente la sua genesi storica corrisponde però alle esigenze del dominio. Oggi con questo termine viene indicato un «metodo di lotta politica, basato su violenze intimidatorie (uccisioni, sabotaggi, attentati dinamitardi, ecc), impiegato in genere da gruppi rivoluzionari o sovversivi (di sinistra o di destra)». Come si vede, questa interpretazione, che cominciò a diffondersi fin dall’Ottocento, si contrappone completamente a quanto detto finora. Nella accezione originaria del termine è lo Stato a ricorrere al terrorismo contro i suoi nemici; nella seconda, sono i suoi nemici che impiegano il terrorismo contro lo Stato. Il capovolgimento di senso non potrebbe essere più esplicativo. L’utilità per la Ragion di Stato di una simile operazione è fin troppo palese. Ma come nasce la mistificazione? Il Terrore in Francia fu opera di uno Stato nato durante una Rivoluzione. Per giustificare il significato attuale del concetto di terrorismo, l’ideologia dominante ha dovuto scambiare i soggetti e attribuire alla Rivoluzione quella responsabilità che in realtà apparteneva allo Stato. Così, oggi ci viene insegnato che il Terrore è opera della Rivoluzione che, in quel lontano contesto storico, si era incarnata in uno Stato. Il Terrore sarebbe quindi sinonimo di violenza rivoluzionaria. Un salto acrobatico della logica che continua a incantare le platee degli spettatori di tutto il mondo, i quali sembrano non accorgersi della truffa pur evidente.
In realtà non si può attribuire il Terrore alla Rivoluzione, al popolo sollevato, giacché è solo quando la Rivoluzione si è fatta Stato che esso è apparso. È una clamorosa menzogna ideologica, nonché un grossolano falso storico, fare del Terrore l’espressione stessa della violenza rivoluzionaria “massacrante”, quella della strada, delle giornate sulle barricate, della vendetta popolare. Prima del 17 aprile 1793 (giorno della fondazione del tribunale rivoluzionario) la violenza esercitata contro il potere, anche quella espressa con forme particolarmente crude, non aveva mai assunto il nome di terrorismo. Né le cruente jacqueries del XIV secolo, né gli eccessi avvenuti durante la Grande Rivoluzione — come ad esempio il corteo delle donne di Marsiglia che portano in giro, in cima a un bastone, le viscere del maggiore De Beausset al grido di «Chi vuole frattaglie?» — sono stati considerati atti di terrorismo. Termine con cui è stata indicata soltanto la violenza repressiva dell’apparato statale nel momento in cui si doveva difendere — per la prima volta nella storia — da un assalto rivoluzionario. Insomma, l’origine storica del termine dimostra come il terrorismo sia la violenza del potere che si difende dalla Rivoluzione, non quella della Rivoluzione che attacca il potere.
Bisogna dire, a questo proposito, che ad incoraggiare la persistenza di questo equivoco hanno contribuito a lungo anche gli stessi rivoluzionari che hanno accettato di buon grado questo appellativo, senza accorgersi che così facendo aiutavano la propaganda di quello Stato che intendevano colpire. E se il concetto di terrorismo può trovare legittimamente spazio in un contesto autoritario della rivoluzione (come dimostrato in Russia da Lenin e Stalin), esso è assolutamente privo di significato, per non dire aberrante, in una prospettiva di liberazione antiautoritaria. Non a caso furono proprio gli anarchici i primi a rivedere l’uso improprio di questo termine, spinti forse anche dagli avvenimenti. Nel 1921 ci fu il tragico attentato al cinema-teatro Diana di Milano che causò la morte e il ferimento di numerosi spettatori, pur avendo come obiettivo il questore della città reo di tenere in prigione alcuni noti anarchici. Malgrado le intenzioni dei suoi autori, un atto di terrorismo. Com’era immaginabile, questo fatto provocò aspre discussioni all’interno del movimento anarchico. Così, di fronte alla condanna del gesto da parte di numerosi anarchici, la rivista Anarchismo di Pisa, senz’altro la pubblicazione più diffusa dell’anarchismo autonomo in Italia, se da un lato continuava a difendere «questa verità anarchica cardinale; cioè dell’inscindibilità del terrorismo dall’insurrezionismo» dall’altro cominciava ad abbozzare le prime riflessioni critiche sul concetto di terrorismo: «O perché mai chiamare e bollar di “terrore catastrofico” — che è proprio dello Stato — l’atto di rivolta individuale? Lo Stato è terrorista, il rivoluzionario che insorge, mai!». Mezzo secolo più tardi, in un contesto di forti tensioni sociali, questa critica verrà ripresa e sviluppata da chi non intende accettare l’accusa di terrorismo lanciata dallo Stato contro i suoi nemici.
Le parole sono sempre state oggetto di evoluzione di significato. Non desta sorpresa che anche il senso del termine terrorismo si sia modificato. Tuttavia non è accettabile che esso contraddica entrambe le sue due caratteristiche originarie, che sono quelle della istituzionalità e della indiscriminazione della violenza. Questa violenza può essere esercitata contro le persone o contro le cose, può essere fisica o psicologica, ma perché si possa parlare di terrorismo bisogna che almeno una di queste due caratteristiche permanga. Ad esempio, si è giustamente parlato di terrorismo per indicare le azioni contro i militanti dell’Eta condotte dagli squadroni della morte dello Stato spagnolo. Queste azioni erano sì indirizzate contro un obiettivo preciso, ma si trattava comunque di una forma di violenza istituzionale contro una minaccia considerata rivoluzionaria. Allo stesso modo, il terrorismo può anche non essere sempre opera delle istituzioni. Ma perché si possa considerare tale, le sue manifestazioni devono colpire in maniera indiscriminata. Una bomba in una stazione ferroviaria, o all’interno di un supermercato aperto, o su una spiaggia affollata: questo si può a ragione definire terrorismo. Anche quando è frutto del delirio di un folle, anche quando viene rivendicata da un’organizzazione rivoluzionaria, il risultato di una simile azione è seminare il panico fra la popolazione.
Quando invece la violenza non è istituzionale e non è indiscriminata, non ha senso parlare di terrorismo. Il singolo individuo che in preda a un raptus di follia stermina la famiglia non è un terrorista. E non lo è neppure il rivoluzionario, o l’organizzazione sovversiva, che sceglie con cura gli obiettivi delle proprie azioni. Quest’ultima è sì violenza, violenza rivoluzionaria, non terrorismo. Non mira a difendere lo Stato, né a seminare terrore fra la popolazione. Se in occasione di simili attentati l’Informazione suole parlare di “psicosi collettiva” o di “intere nazioni che tremano”, è solo in omaggio alla vecchia menzogna che vuole identificare l’intero paese con i suoi rappresentanti (per meglio giustificare il perseguimento di interessi privati dei pochi in nome e a scapito di quelli sociali dei molti). Se qualcuno dovesse cominciare ad uccidere politici, industriali e magistrati, ciò seminerebbe terrore solo fra i politici, gli industriali e i magistrati. Nessun altro ne sarebbe materialmente toccato. Ma se qualcuno ponesse una bomba su un qualsiasi treno, chiunque potrebbe esserne vittima, senza esclusioni: il politico come il nemico della politica, l’industriale come l’operaio, il magistrato come il pregiudicato. Nel primo caso siamo di fronte a un esempio di violenza rivoluzionaria, nel secondo si tratta invece di terrorismo. E per quante obiezioni, critiche e perplessità si possano sollevare sul conto della prima forma di violenza, non la si può certo equiparare alla seconda.
Detto questo, torniamo al quesito iniziale. Fra il re che fece massacrare la folla e l’anarchico che sparò sul re, chi è il terrorista?
[Diavolo in corpo, n. 3, novembre 2000]