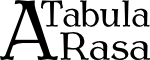Tradotto dal francese su Finimondo.org , inizio 2013
La repressione e il suo piccolo mondo
Alcune riflessioni per non fare di un tema particolare un punto isolato
Oggigiorno, la constatazione che viviamo sotto il regno della separazione è piuttosto condivisa e non ha nulla di molto originale. Non mancano le analisi che affrontano questo meccanismo, anche se i partigiani dell’economicismo tendono ancora a ridurlo alla sua espressione più semplice. Soprattutto, ciascuno sente in modo profondo e quotidianamente fino a che punto l’organizzazione sociale che poggia su talmente tante separazioni contribuisca a renderci estranei gli uni agli altri così come a noi stessi, quanto ci mutili del e dal nostro ambiente, quanto la divisione del tempo, dello spazio, dell’attività partecipi allo spossessamento individuale e generalizzato. È quindi logico che diverse discussioni vertano su come demolire questo stato di cose, riflettendo sugli eventuali legami da creare fra coloro che vivono questa esigenza, ma anche sulle maniere di affrontare e collegare i diversi aspetti del dominio senza gerarchizzarli. Perché, in fin dei conti, lo scopo non è forse quello di farla finita con le miserie che genera?
Eppure, non tutto è così semplice e non è raro che lotte che si pretendono radicali riproducano abbastanza rapidamente alcune forme di frammentazione. È quanto avviene, ad esempio, quando categorie inerenti il sistema che auspichiamo di veder scomparire vengono riprese tali e quali, specialmente come punto di partenza di un possibile denominatore comune. Come se fare dei lavoratori, precari, prigionieri, senza-documenti o altri «senza» degli ipotetici soggetti di lotta o di trasformazione sociale non corrispondesse esattamente a ciò che si vuole che siamo: una giustapposizione di identità parcellizzate rinchiuse in differenti scomparti, per quanto assorbenti e permeabili. Anche se queste definizioni sono legate a situazioni sociali ben reali, esse nondimeno riducono gli individui alle sole posizioni loro assegnate dalla società e in ogni caso non dicono nulla di ciò che sono, fanno, vogliono o non vogliono.
Allora, piuttosto che riprodurre all’infinito queste categorie, talvolta erette a identità, non sarebbe possibile associarsi sulla base di un comune denominatore che superi la condizione particolare di ciascuno? Un denominatore comune che non sarebbe certamente un Tutto, ma potrebbe incarnarsi in negativo come in positivo nel rifiuto, nei desideri, nelle idee condivise e portate da ciascuno. Approfondire questi aspetti contribuirebbe forse ad uscire dalla dicotomia interiorità/esteriorità inerente ad ogni soggetto/identità, ma anche ad avanzare verso progetti in tensione con le nostre aspirazioni reali, come per esempio questa volontà feroce di farla finita con tutti i compartimenti e le gabbie contro cui ci scontriamo (frontiere, reclusioni, salariato...).
Un altro freno alla messa in discussione di tutte le separazioni che ci sono imposte risiede anche nel concepire le nostre lotte come se fossero inevitabilmente parziali. Ora, più un terreno di lotta verrà subito strettamente definito, più gli saranno imposti limiti difficili da superare, sia a livello degli echi che potrebbe avere, sia della critica dell’insieme di questo sistema sociale. I salti qualitativi — che non sono per forza di cose quantitativi — sono oggi certamente possibili, ma allora diventa indispensabile che coloro che li auspicano agiscano concretamente affinché la lotta non ruoti su se stessa, e non si focalizzi sui soli obiettivi considerati a torto o a ragione come i più facilmente e rapidamente raggiungibili. In una prospettiva emancipatrice, perché scindere in modo arbitrario i «bisogni» (più o meno immediati secondo i criteri) dalle voglie e dai desideri che li accompagnano? Perché si dovrebbe mantenere una qualsivoglia ambiguità su ciò che pensiamo circa il funzionamento di questo sistema, e sull’antagonismo che auspichiamo di opporgli? In nome di cosa adoperarsi a difendere o a rivendicare delle briciole, invece di alimentare un possibile denominatore comune, come per esempio il disgusto per lo sfruttamento e per la schiavitù salariale ed il gusto per il sabotaggio di questo mondo; la critica dell’urbanesimo concentrazionario e le acrobazie offensive che ne conseguono? Perché isolare alcune parti da un tutto che non si tratta né di riformare né di umanizzare, bensì di distruggere?
Ovviamente, ciascuno è libero di attaccare il mostro dei rapporti alienati dall’angolazione che gli sembra più propizia o che preferisce. Tuttavia, è dal modo di condurre questi attacchi — ovviamente legato al perché — che dipenderà anche la loro dimensione sovversiva. A partire da qui si pongono tutta una serie di domande (dalle conseguenze eminentemente pratiche) relative agli obiettivi che ci proponiamo di raggiungere, ai mezzi che riteniamo adeguati, a ciò a cui aspiriamo e a quanto speriamo di sviluppare più o meno a lungo termine, alle nostre prospettive generali insomma. Si tratta di questioni essenziali che fanno parte della lotta per riappropriarci delle nostre vite, e non di semplici giochi di spirito. Inoltre le risposte che ognuno dà, nel quotidiano come in qualsiasi lotta specifica, possono ben costituire una base per superare le false separazioni.
Certo, lo scopo non è tentare di unificare ciò che — per vere ragioni di sostanza, come visioni o prospettive antinomiche — risulterebbe inconciliabile. Del resto ciò potrebbe avvenire solo a prezzo di concessioni di ordine politico e di rinunce essenziali. L’idea è piuttosto di ricercare e di annodare complicità all’interno di percorsi di lotta contro l’autorità e quanto essa vuole imporci.
Nel vivo dell’argomento: «repressione e anti-repressione»
Legata alla sopravvivenza o ai desideri inappagati di vivere liberi, la repressione s’impone con diverse forme. Vista l’estensione delle repressioni esercitate da questo sistema attraverso tutti i suoi meccanismi e date le pressioni quotidiane prodotte dall’insieme dei rapporti sociali ― di cui siamo parte coinvolta e che a nostra volta riproduciamo ― c'è parecchio da fare... In questo senso, lottare contro la repressione e ciò che la sottende consiste né più né meno che nel battersi contro l’insieme dei rapporti di potere e per la libertà. Ma di solito non è questo che si intende con ciò.
Se la repressione fa certo parte della quotidianità, essa è anche una questione che si pone immediatamente in ogni lotta, particolarmente quando questa non fa mistero della sua volontà di sconvolgimento sociale. Tentare di operare direttamente per la distruzione di questo sistema ci espone ai suoi fulmini, come ci ha ricordato qualche vicenda di questi ultimi anni in Francia. Quel che è l’abituale destino in altri paesi, ovvero una repressione specifica contro idee e azioni che minacciano e mirano a rovesciare l’ordine stabilito, è quindi nuovamente all’ordine del giorno.
Tuttavia in entrambi i casi, che si tratti della quotidianità dell’addomesticamento o di lotte particolari, la maniera in cui si analizza la repressione in generale provoca la modalità con cui si decide di affrontarla pubblicamente. Con le conseguenze assai pratiche che ciò non manca di avere.
Concentrarsi unicamente su questo o quello strumento repressivo (il dna, il flash-ball, l’ennesima legge «securitaria»...) allorché l’arsenale già rifornito non cessa di aumentare, equivale spesso a porsi su un terreno stabilito dallo Stato. È questo il caso quando lo studio tecnico di certe «innovazioni» o perfezionamenti sostituisce l’analisi dei contesti in cui si inseriscono e ancor più quando la contestazione si limita a reclamarne l’abolizione, spalancando la via al riformismo. Questo può accadere anche perché si riprendono categorie create da altri, se non per rivendicarle, quanto meno per farvi riferimento in maniera esagerata. Si potrebbero citare alla rinfusa i «delinquenti di periferia», i «terroristi», i «militanti» o i «membri» di questa o quella «mouvance». Nessuno ha il monopolio di certe pratiche offensive, a meno di negare la dimensione sociale degli illegalismi. Più in generale, attaccare la repressione facendo di una mosca un elefante non permette affatto di allargare il campo di intervento verso una messa in discussione della Legge in quanto tale. Allo stesso modo, considerare come inaccettabile questa o quella repressione particolare conduce quasi inevitabilmente a tentare di dimostrarne il carattere infondato o ingiusto — in particolar modo mettendo in rilievo l’innocenza o una qualche pretesa deviazione del diritto.
Gli strilli di sdegno che ricorrono puntualmente a proposito di una sedicente «criminalizzazione del movimento sociale» ne sono un esempio banale. La «legittimità» degli accusati o di certe azioni dovrebbe evidentemente derivare dal loro carattere «militante» o dal contesto della lotta ― con la sciocchezza che un gran numero di partecipanti costituisca per di più una circostanza attenuante. Ciò significa che degli individui o delle pratiche che non rientrano in queste condizioni sarebbero legittimamente condannabili? A forza di insistere sull’aspetto collettivo di un movimento o su quello condiviso di una pratica in determinati momenti, non si finisce per spezzettare la conflittualità in tanti piccoli frammenti più digeribili dalla repressione, e soprattutto per ignorare una gran parte dell’antagonismo, quella praticata quotidianamente in maniera diffusa, che ha ragioni proprie e utilizza tutti i mezzi legati all’immaginazione e alla determinazione?
Un altro esempio di tale chiusura sul terreno dello Stato è la polarizzazione su certi tipi di procedura (come l’anti-terrorismo) considerati delle eccezioni, il che equivale a riconoscere, magari indirettamente, la legge, la giustizia e l’ordine «normale» che le sottende. In questa logica non sorprende che vengano utilizzati i classici mediatori istituzionali (partiti, sindacati, media...) per rivolgersi allo Stato, affinché quest’ultimo, messo davanti alle proprie responsabilità, si presume corregga i suoi abusi o gli errori dei suoi servitori. Tutto avviene quindi come se, in nome dell’urgenza e di una certa «gravità della situazione», si potesse di colpo sbarazzarsi della questione del funzionamento di questo sistema, mettere in primo piano le libertà formali che dovrebbero essere garantite, fare leva sull’indignazione ovvero sul recupero cittadinista, pronti a riabilitare di fatto l’idea di democrazia, di delega e di rappresentazione.
Questo genere di riflesso antirepressivo, anche qualora le sue intenzioni non fossero strettamente politiche, finisce col neutralizzare qualsiasi possibilità di sovversione. Esso viene generato anche e soprattutto quando la repressione, al di là di un caso specifico, viene vissuta come un momento separato, una sorta di parentesi in cui tutte le contraddizioni sarebbero abolite. Ed è così che l’azione diretta può allegramente coabitare con strategie opposte, finendo sempre con l’essere strumentalizzata a loro profitto, e che diventa possibile utilizzare come sostegno qualsiasi domestico del dominio e pompiere di servizio (eletti, preti, partiti o sindacati, poco importa). Questa logica democratica del tutto compatibile, finché si resterà ragionevoli, contribuisce per l’appunto ad integrare la contestazione, ad eliminare il dissenso e contribuisce al raggiungimento da parte dello Stato dei suoi obiettivi di contenimento. Un simile rovesciamento è particolarmente inquietante e stridente, quando una delle pretese di partenza era la messa in discussione dell’ordine esistente.
Repressione, Stato e rapporti sociali
Un altro modo di affrontare la questione potrebbe consistere viceversa nel non fare della repressione una eccezione dell’ordine di questo mondo, anche quando colpisce in maniera specifica coloro che sono determinati a minarne le basi.
Pur interessandosi soltanto dell’apparato poliziesco, giudiziario e carcerario, è difficile non accorgersi di tutti i mezzi di cui dispongono e fanno uso per mantenere e preservare l’ordine sociale. Che sia per difendere la sacrosanta proprietà, il monopolio della violenza, i valori e le norme dominanti erette a leggi, lo Stato si è dato da un bel pezzo i mezzi per controllare, minacciare e punire; e non ne fa a meno. Non si possono quindi attaccare sostanzialmente questi pilastri della società senza avviare una critica diretta allo Stato in sé, la cui sola esistenza implica la repressione dei desideri e delle volontà individuali nel nome di un qualche interesse superiore o di un supposto «bene comune». Un aspetto troppo spesso assente quando la lotta si ferma più o meno volontariamente sulle espressioni visibili della polizia (che non si riduce alle soli uniformi), della giustizia (che copre un campo ancora più vasto di tutti i codici penali) e della prigione (così presente al di là delle mura).
Allo stesso modo, non si può separare ulteriormente ciò che va intrinsecamente di pari passo, ovvero l’attitudine inevitabilmente coercitiva dello Stato dal suo aspetto presunto «sociale», come se questo aspetto non fosse parte integrante dell’insieme della sua gestione, come se non modellasse e non invadesse le scuole, i luoghi di lavoro, gli organismi sociali e tutti gli angoli in cui abitiamo.
L’oppressione che subiamo e contro cui occorre lottare è anche un rapporto sociale. Talvolta, ad insistere troppo sulla coercizione e sui suoi strumenti, si arriva facilmente ad esagerarne gli effetti ― già enormi ― in relazione alle possibilità di affrontarli, ma si rischia soprattutto di non prendere in considerazione altri meccanismi sociali che lavorano largamente alla pacificazione (in particolar modo nei sistemi democratici) e che pure si basano su diverse forme di consenso, adesione e partecipazione.
In realtà, la questione non è di rifiutare a priori qualsiasi lotta che parta da questa o quella struttura o processo repressivo nell’attaccare questo mondo, ma di fare sì che tutte le estensioni qui poste siano presenti. Per non disgiungere la repressione dalla critica dello Stato nel suo insieme, e nemmeno ridurre quest’ultima a dispositivi separati dai rapporti sociali, si può ad esempio affrontare la questione della prigione sociale, che apre ampi sbocchi teorico-pratici e possibilità di approfondimento.
Lottare contro tutte le prigioni implica infatti di considerare i meccanismi di controllo e di reclusione che attraversano la società complessivamente. Non concentrandosi più su un unico aspetto specifico della gestione carceraria o sui nuovi dispositivi repressivi o di sorveglianza, è possibile cogliere in uno stesso movimento i codici morali e sociali che costituiscono altrettanti strati partecipanti al dominio e che possono così incarnarsi concretamente... Per citarne solo alcuni, vi è il rapporto con la legge (quale essa sia) e col conflitto, la collaborazione cittadinista, il controllo sociale diffuso sui diversi aspetti della vita di ognuno. Attaccare quanto ci rende reclusi quotidianamente comporta allora una grande sfida: portare contenuti e pratiche risolutamente anti-autoritari nel cuore degli incontri che speriamo di fare in una lotta contro i tanti muri di questa prigione sociale.
Allo stesso modo, una lotta specifica contro questa o quella struttura carceraria può avere come scopo quello di attaccarla direttamente per distruggerla, ma mirando anche al «mondo che la produce». Non si tratta di una inutile parola o di un semplice slogan, quando gli obiettivi che una tale lotta si dà sono anche la diffusione di idee emancipatrici, la diffusione di maniere di auto-organizzazione che permettano a chiunque di prendere l’iniziativa al di fuori delle mediazioni istituzionali e di ogni gerarchia, così come l’estensione delle ostilità individuali e collettive in una prospettiva rivoluzionaria.
Altrettanti cose da approfondire in questo genere di lotte come in qualsiasi conflitto che desideriamo sollecitare o a cui decidiamo di partecipare.
Anti-repressione e solidarietà
Una critica solitamente rivolta a coloro che fanno dell’«anti-repressione», e al riflesso anti-repressivo in generale, è la tendenza a trascurare provvisoriamente il resto delle proprie attività per limitarsi ad una stretta autodifesa. Troppo spesso infatti, quando la repressione viene a bussare alla porta, non solo paralizza le energie con i suoi effetti diretti e la sua pendente spada di Damocle, ma riesce anche a monopolizzare il terreno ed il calendario. Succede così che a forza di concentrare l’essenziale del tempo e degli sforzi su quanto capita ai compagni tutti, si giunge a perdere di vista ciò contro cui essi si battono e a trascurare, ovvero tralasciare, il perché ci battiamo. Triste paradosso a cui si oppone come effetto speculare la proposta, sfortunatamente spesso concepita in maniera troppo astratta e separata, di proseguire genericamente le lotte. Come se nulla fosse?
Non si tratta qui di fare una proposta di lotta anti-repressiva, ancor meno se questa dovesse sostituirsi all’offensiva contro il complesso del sistema. Sappiamo che il terreno dell’opposizione alla repressione è minato, ma grosso modo né più né meno di tutto ciò che questo mondo ci riserva, non avendone scelto noi i contorni. Come in ogni lotta che si presenti, spetta a noi decidere cosa vogliamo farne; scegliere di spostarne i termini, se sono troppo limitanti; di tentare di condurla verso i punti deboli, ove esistano possibilità di echi, ovvero di incontri complici nell’antagonismo. Pertanto, in nome di cosa si può rifiutare di prendere di petto questo aspetto dello scontro? Considerandoli nel vasto contesto della guerra sociale cui prendiamo parte, non dovrebbe essere difficile né artificiale rispondere a questo genere di colpi collegandoli alle altre oppressioni e soprattutto alle altre rivolte.
La solidarietà non si basa sul fatto repressivo in quanto tale, ma su ciò in cui ci riconosciamo in relazione ad esso, in ciò che può motivare degli individui, delle lotte, delle azioni... Molto più del sostegno a persone in mano alla repressione, la solidarietà è soprattutto una maniera di continuare a portare in avanti un antagonismo con i suoi perché. Quando lo Stato cerca di far rientrare i recalcitranti nei ranghi, sarebbe un errore spingerli in nuovi compartimenti, contribuendo ad isolarli dal resto della conflittualità sociale (ad esempio, nessun bisogno di essere «militanti» o vicini ad una «vittima di omicidi polizieschi» per riconoscersi nell’ostilità contro gli sbirri e contro il sistema che essi contribuiscono a mantenere in atto). La rabbia e la rivolta contro l’esistente si manifestano in permanenza, in molte maniere e in molti luoghi. E se animano anche noi, esprimiamole allora con parole ed azioni, in un reciproco scambio con ciò che ci parla e ci sta a cuore, come il rifiuto dell’autorità e i nostri desideri di libertà. Perché non è forse questo che desideriamo vedere diffondersi?
Nello stesso modo in cui il meccanismo repressivo non può essere assimilato a semplici procedure o a brutte giornate trascorse sui banchi di un tribunale, l’autodifesa ― soprattutto quando si vuole cambiare il mondo ― non può ridursi alla sola perizia, anche se condivisa, in materia giuridica. Se possiamo cogliere queste occasioni (interventi polizieschi, incarcerazioni, processi) come tante altre per fare dell’agitazione, non è con sapienti calcoli sugli effetti che tutto ciò avrà su un esito giudiziario. Lo Stato ha le sue ragioni che non sono le nostre, e in ogni modo l’idea non è quella di rivolgersi al potere, ma di tentare una volta di più di stabilire un dialogo all’interno della conflittualità. In questo senso, la nozione di rapporto di forza non si limita al tempo di una vicenda, di un processo o di una qualsivoglia «campagna». Allo stesso modo, la riuscita o il fallimento non si misurano col metro della quantità di persone che vi sono direttamente interessate o della pesantezza delle condanne, ma soprattutto col modo in cui avremo contribuito a rafforzare e ad estendere un antagonismo al tempo stesso generale e individuale. Questo è certamente difficile da valutare, fatta eccezione per gli echi vicini o più «lontani» che possono giungere a noi e che non sono trascurabili. D’altronde, spesso si cerca invano di quantificare gli effetti di tale o talaltro intervento, da tanto essi possono attraversare lo spazio ed il tempo e superarci, come il campo delle nostre conoscenze immediate. Sta a noi quindi definire i nostri propri criteri e sperimentare differenti miscugli solidali sempre più esplosivi. In quest’ottica, tentare di opporsi nella maniera più offensiva e sovversiva possibile a tutto ciò che ci rinchiude e ci distrugge giorno per giorno ― di cui polizia, giustizia, prigione costituiscono in effetti solo una parte ― non è tanto segno di una autodifesa militante, per quelli che tengono a questo termine (con quello che siamo, le nostre idee, le nostre aspirazioni e le pratiche che ne derivano), quanto di una determinata concezione di lotta.
La solidarietà resta una delle nostre armi da affilare contro un sistema che funziona anche sull’intimidazione e sull’atomizzazione. Con un poco di immaginazione e di creatività, associate ad una analisi del contesto sociale in cui ci si trova, si potrebbe contribuire a spezzare un po’ questi due aspetti fondamentali del dominio. Dinanzi a tutti gli ostacoli che costellano il cammino, una certa coerenza e continuità non contribuiscono soltanto ad evitare la frammentazione delle nostre attività e delle nostre individualità, ma potrebbero anche diventare un punto d’appoggio per condividere e approfondire con altri una tensione comune verso la libertà.