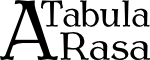Lope Vargas
Per regolare i conti
Inviolabilità
Se si pensa che nella tradizione cristiana già il primo uomo apparso sulla terra disobbedisce al precetto divino ed incorre per questo nella punizione, e che a commettere il primo omicidio è un suo diretto discendente, è evidente come l’origine della giustizia si perda nella notte dei tempi, nascendo in risposta al problema posto da chi disturba l’ordinamento sociale ed economico.
Motivo per cui dichiararsi contro la giustizia risuona all’orecchio dei più come uno scherzo di cattivo gusto, una provocazione, una follia, specialmente in un’epoca giustizialista come quella che stiamo attraversando. Un luogo comune di secolare solidità vuole infatti che non si possa avversare la giustizia, perché altrimenti ciò significherebbe essere a favore dell’ingiustizia, del sopruso, della tirannia. E questa convinzione è penetrata talmente a fondo nell’animo umano che tutti coloro che nel corso della storia hanno criticato la giustizia si sono sempre premurati di specificare di essere contrari solo ad un suo particolare operato, a una sua cattiva gestione, a una sua applicazione considerata errata. Ma la giustizia in sé, la giustizia in quanto tale, è sempre stata considerata un concetto inviolabile.
Dati per scontati sia il disordine della condotta umana che la necessità di porvi un freno attraverso la giustizia, il solo dubbio capace di macchiare la nobiltà di questa misura riguarda al più la rettitudine di chi è incaricato ad amministrarla. La dea munita di spada e bilancia per manifestarsi ha bisogno di sacerdoti, i quali a volte possono non dimostrarsi all’altezza del compito affidatogli. Tutte le discussioni sulla giustizia si esauriscono qui, con la richiesta di un giudice umano capace di rompere con le tradizioni di una magistratura mummificata e fossilizzata negli articoli di un codice feroce. Per esprimersi “realmente”, la giustizia non ha bisogno di un giudice funzionario, nemico naturale di chi ha violato il codice e che distribuisce sentenze in maniera automatica, ma di un giudice che faccia sentire il soffio dell’eguaglianza e della fratellanza nelle assoluzioni come nelle condanne. Perché — ci viene detto — è la legge che deve essere fatta per l’uomo, e non l’uomo per la legge. Chissà!
Soggezione
«Giustizia (s.f.): un articolo che lo Stato vende, in condizioni più o meno adulterate, al cittadino, in ricompensa della sua fedeltà, delle tasse e dei servizi resi»: Ambrose Bierce
In effetti esiste più di un buon motivo per cui le critiche alla giustizia hanno avuto come oggetto principale la sua pretesa neutralità. Se è vero che Giustizia è sinonimo di Virtù — di una virtù oserei dire trascendentale che, se magari non è più espressione della volontà divina, rimane comunque lontana dalle meschinità umane — dall’altro lato non si può nascondere che essa si manifesta concretamente grazie a leggi fatte dall’uomo. E l’uomo, si sa, non è perfetto.
Qualcuno ci ha tramandato che l’origine della parola legge derivi dalla forma indoeuropea légere, cioè leggere. La Legge che tutti noi dobbiamo osservare è stata scritta, poco importa se sulle tavole di Mosé o in un codice. La questione cruciale appare subito chiara: chi ha scritto la legge? Evidentemente chi ha avuto il potere di farlo. E perché lo ha fatto? Altrettanto chiaramente, per difendere i propri privilegi. Motivo per cui la legge, in quanto tale, è necessariamente arbitraria poiché obbedisce agli interessi di chi può imporla, vale a dire di chi detiene l’autorità. Dietro la retorica che la vuole un nobile ideale perseguito dall’essere umano, la giustizia non è altro che un modo di avallare un determinato sistema di valori. Non a caso le interdizioni che sono state imposte attraverso la storia sono così diverse tra loro che non si potrebbe trovare una sola pratica universalmente considerata come “criminale”, neanche l’incesto o il parricidio. Se la Giustizia fosse davvero uno strumento superiore i cui principi normativi toccano l’essenza dell’essere umano, le sue leggi sarebbero eterne ed universali e l’uomo troverebbe la propria realizzazione attraverso il loro adempimento. Invece queste leggi cambiano continuamente — a seconda dell’ordinamento sociale, politico ed economico che devono regolamentare — e questo può significare una cosa sola: attraverso le leggi si manifesta un volere umano, non certo divino.
Ma riconoscere il carattere arbitrario della giustizia non comporta di per sé una sua messa in discussione. Per quanto di parte, la giustizia appare comunque indispensabile. Nel mito che Platone fa esporre a Protagora nel dialogo omonimo, si dice che finché gli uomini non impararono l’arte politica, che consiste nel rispetto reciproco e nella Giustizia, non poterono riunirsi in città ed erano attaccati dalle fiere. Il rispetto della giustizia permetterebbe quindi agli esseri umani di convivere. Ancora oggi, è opinione diffusa che il venir meno delle regole su cui si fonda la nostra civiltà scateni gli istinti più feroci. Senza una autorità, rappresentata dallo Stato, che ne moderi gli appetiti, i singoli individui non sono in grado di vivere assieme. Lasciati a se stessi, gli individui sostituirebbero la forza della legge con la legge della forza (la polizia come unico baluardo contro il dilagare di omicidi, stupri e stragi di innocenti). La giustizia nasce quindi dalla constatazione che nell’individuo non c’è legge, non c’è ordine. Dunque lo Stato nasce a posteriori così come le regole, le leggi, le convenzioni morali, e poggia sul ribollente magma dell’anomia morale. L’individuo si sottomette allo Stato soltanto perché ritiene di aver bisogno di salvaguardare e stabilizzare i suoi rapporti. Costruisce un ordine esterno per placare il disordine che cova dentro di sé, ma una tale organizzazione non avrà mai nulla a che fare con la sfera interiore, con l’animo umano e le sue più segrete (e paurose) pulsioni. L’individuo, essere mostruoso, deve lasciar il posto al cittadino, al soggetto dello Stato, il solo in grado di vivere senza causare danni poiché scrupoloso osservatore dei precetti della giustizia. La legge è quindi ciò che ci lega, nel suo duplice significato: ciò che ci unisce, il nodo del vincolo sociale, è anche ciò che impedisce i nostri liberi movimenti.
Una simile concezione la dice lunga sul conto del mondo che la adotta, i cui abitanti necessitano di proibizioni esterne in mancanza di una propria consapevolezza interiore, si sentono uniti da una comune competitività e non dalla solidarietà, si percepiscono come se ognuno fosse il secondino dell’altro e pensano che la libertà rappresenti una catastrofe per la loro esistenza, anziché considerarla come ciò che potrebbe darle un senso. Purtroppo, tutto ciò non è straordinario. Siamo talmente addomesticati da una educazione che fin dall’infanzia cerca di sedare in noi lo spirito di indipendenza e di promuovere quello di soggezione, siamo talmente abituati a una vita controllata da uno Stato che ne legifera ogni aspetto — nascita, sviluppo, amori, amicizie, alimentazione, morte — che alla fine perdiamo ogni iniziativa, ogni autonomia, ogni capacità di affrontare e risolvere direttamente i problemi che la vita ci pone. Ecco perché, all’interno di ogni Stato, una nuova legge è considerata come il rimedio per tutti i mali. Invece di cercare di risolvere il problema comprendendone le cause, si comincia col chiedere una legge che vi metta riparo. La strada fra due città è impraticabile? Occorre una legge che regoli il traffico. Un esecutore della legge ha abusato del suo potere? Occorre una legge che ordini ai gendarmi di essere più rispettosi. Gli industriali intendono ridurre i salari? Occorre una legge che difenda gli interessi dei lavoratori. Insomma, per affrontare i conflitti che sorgono dall’attività dell’uomo c’è solo bisogno di una legge appropriata. Attraverso l’applicazione della giustizia, lo Stato pretende di moderare e gestire questi conflitti. Si può quindi constatare che la giustizia non elimina i conflitti, non li previene affatto. Niente e nessuno può farlo. La giustizia si limita a normalizzarli, a codificarli. Così facendo, li aggrava e ne provoca degli altri fino ad arrivare all’assurdità del rimedio “criminogeno”, rimedio peggiore del male.
Da parte loro, i nemici dello Stato hanno pensato di risolvere il problema in altro modo, attribuendo ogni contrasto umano al funzionamento dello Stato stesso. Una volta che la “criminalità” viene definita la reazione a un’organizzazione difettosa della società, appare più concreta la possibilità di sopprimerne le cause trasformando i rapporti umani. L’abolizione del crimine e della carcerazione è stata infatti una delle preoccupazioni primarie del comunismo utopico, che sostituì alla rassegnazione gaudente dei cristiani di fronte al peccato, una ricerca razionale dei rimedi all’esistenza del male. I suoi grandi principi erano semplici: il furto e l’omicidio non hanno più ragione d’essere nel momento in cui la proprietà privata e la famiglia lasciano il posto all’esistenza comunitaria. Se la felicità è garantita per tutti, gelosia e risentimento svaniscono portandosi con sé gli atti di violenza generati da questi sentimenti. Una simile armonia sembra essere però ben lontana dalle passioni umane e non può essere immaginata senza un poderoso riduzionismo. I vari tentativi effettuati in passato di sperimentare praticamente l’utopia hanno sempre generato conflitti, che non ne volevano sapere di scomparire d’un tratto, rivelando l’astrazione della felicità proposta. Contro lo Stato e la sua giustizia, l’armonia sociale non saprebbe realizzarsi che a prezzo di costumi austeri e frugali. «Ho letto gli scritti di qualche celebre socialista — faceva notare Victor Hugo nel maggio 1848 — e sono rimasto sorpreso nel vedere che abbiamo, nel diciannovesimo secolo qui in Francia, tanti fondatori di conventi». In effetti, l’arcadia socialista non prometteva la felicità che a placidi cenobiti. I suoi fautori arrivarono spesso alla perfezione totalitaria poiché — per estirpare l’energia pericolosa presente nell’essere umano ed evitargli ogni occasione di scontro con altri — teorizzarono una minuziosa organizzazione di ogni istante di vita.
Astrazione
Dunque lo Stato pretende che l’essere umano sia cattivo, per legittimare la propria esistenza. Nelle sue mani, la giustizia è un’arma contro la minaccia della barbarie. I nemici dello Stato invece pretendono che l’essere umano sia buono, per sostenere l’inutilità dello Stato. Nelle loro mani, la giustizia è una siringa da usare per scopi terapeutici. E se l’essere umano non fosse né buono né cattivo, ma semplicemente in preda ai suoi tormenti, cosa resterebbe della giustizia? Se la vita non avesse una meta universale, non dovesse scoprire alcuna verità, se la natura umana non avesse alcuna essenza, se non esistesse nulla di giusto da contrapporre a ciò che è sbagliato, giacché esiste solo ciò che è mio e ciò che non lo è, non è forse vero che ogni norma regolatrice il comportamento umano diventerebbe un insopportabile sopruso? Di fatto, se la giustizia ricorre alla polizia per imporsi, è proprio perché il carattere della giustizia è poliziesco. La tutela delle condizioni essenziali della convivenza civile — di cui la giustizia si fa garante — si traduce praticamente nel controllo della pace sociale all’interno dello Stato (o della Comunità); l’obbligo per ciascuno di uniformare il proprio comportamento a quanto dettato dalla legge, pena la privazione della libertà, non garantisce affatto l’equità della giustizia ma ne indica soltanto la ferocia. Una norma valida per tutti non è affatto equa, essendo astratta e, quel che è peggio, trasforma anche noi in astrazioni. La giustizia che punisce l’omicidio con la reclusione a vita o con la morte non sa chi sia la vittima, chi l’assassino e quali le ragioni del suo gesto, né conosce fino in fondo tutte le conseguenze. Con la farsa delle circostanze “aggravanti” e di quelle “attenuanti”, la giustizia tenta di immettere un tocco di vita nelle sue sentenze, senza per altro riuscirvi, in quanto è consapevole della propria freddezza. Ma la condotta umana non può essere codificata, ha molteplici cause ed è frutto dell’incontro casuale di circostanze e di caratteri diversi. Una norma non può racchiudere questa totalità, non la può cogliere nella sua unicità, è costretta a fare astrazione dalla realtà concreta dei singoli se vuole imporsi a tutti.
Ma i conflitti che sorgono fra esseri umani non sono astratti, sono reali. Sono il risultato di rapporti sociali concreti, della diversità degli interessi, dei sogni, del carattere degli individui. Nella sua astrazione, la giustizia isola l’individuo in carne e ossa separandolo dal rapporto e dall’ambiente sociale in cui il suo atto ha avuto luogo, negandone così il significato. Ancor di più, la giustizia separa l’individuo-accusato dal dibattito che lo riguarda delegando la sua autonomia, come avviene nel resto della vita sociale, ai suoi rappresentanti: gli avvocati. Così come i cittadini delegano allo Stato il compito di decidere come vivere la loro vita, così delegano alla giustizia il compito di come risolvere i loro conflitti. In quanto meccanismo separato di risoluzione dei conflitti, la giustizia non viene meno se si conferiscono le sue funzioni ad un’altra entità, posta al di sopra degli individui, ma più fluida, rinnovabile, sottoposta ad elezioni o controllata da assemblee popolari. Una giustizia “più umana” non cesserebbe di essere una macchina per separare il Bene dal Male, di esprimersi indipendentemente dai rapporti sociali e quindi inevitabilmente contro di essi.
Vendetta
Il sogno di ogni totalitarismo è quello di bandire la violenza (fatta eccezione per quella dello Stato, naturalmente). Se tutti obbedissero ai dettami della Giustizia, non ci sarebbero conflitti, non ci sarebbe violenza. Ma un mondo senza trasgressione, senza conflitti, senza disordine, è un enorme campo di concentramento. Un mondo pacificato è un mondo che ha rinunciato ai rumori della sua maggiore ricchezza, la diversità, a favore della quiete dell’omologazione. Per quanto deprecabile, la violenza è una caratteristica umana. Il punto non è di assegnare allo Stato il monopolio della violenza, né di trasformare ogni individuo in un perfetto non violento. Non si tratta di cancellare i conflitti dalla nostra vita, ma di affrontarli nella loro singolarità. E la loro risoluzione va ricercata da coloro che ne sono direttamente coinvolti, senza delegarla a istituzioni esterne (lo Stato), senza delimitarla in spazi circoscritti (tribunali), senza accontentarsi di risposte automatiche scritte da altri (codice penale).
Ora la Giustizia, risposta pubblica al “problema” dei conflitti, definisce con un termine spregiativo la risposta individuale a questo stesso problema: vendetta. Tanto la giustizia è nobile, tanto la vendetta è abietta. Ad essa si accompagna l’eccesso, il sopruso, l’approssimazione. Come se la giustizia non fosse in sé eccesso, sopruso, approssimazione. Paradossalmente, per definire questa esecrata determinazione dell’individuo di non delegare a nessuno la risoluzione dei propri contrasti con altri si è scelto un vocabolo dalla ben strana origine. La vindicta, infatti, era la verga con cui si toccava lo schiavo che doveva essere posto in libertà. Spada della giustizia e verga della vendetta sono entrambe in mano a chi detiene il potere, è vero, ma se la prima è promessa di punizione e castigo la seconda reca con sé il sapore della libertà. In realtà, nulla dimostra che la vendetta sia la strada obbligata per chi rifiuta la giustizia. Solo all’interno di una logica economica di compensazione, tanto cara al capitalismo, ad una offesa deve corrispondere un’altra offesa di pari entità. La giustizia regola i conti e questi, alla fine, devono sempre tornare. È questo un lascito dell’eredità delle rivoluzioni liberali borghesi che, dovendo assicurare a ciascun cittadino un trattamento identico di fronte alla legge, dovevano garantire al meccanismo delle decisioni amministrative un funzionamento identico per ogni cittadino.
Ma un conflitto non ha soluzioni a senso unico, perché contempla infinite possibilità (anche l’indifferenza o la lontananza). In ogni modo solo chi lo vive sulla propria carne può conoscere la risposta, che non può essere codificata. Motivo per cui con l’autonomia dell’individuo la giustizia scompare, e con essa anche l’ingiustizia. Non si deve credere infatti che negare la giustizia significhi affermare l’ingiustizia. Non più di quanto negare l’esistenza di Dio implichi l’adorazione di Satana. In fondo non aveva tutti i torti Hobbes, pensatore non sospetto di simpatie sovversive, quando affermava che la Giustizia consiste semplicemente nel mantenimento dei patti e che pertanto dove non c’è Stato — cioè un potere coercitivo che assicuri il mantenimento dei patti — non c’è né giustizia né ingiustizia.