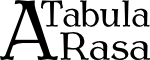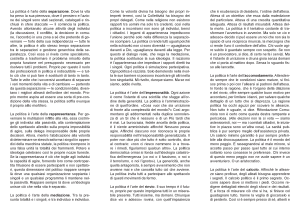Dieci pugnalate alla politica
La politica è l’arte della separazione. Dove la vita ha perso la sua pienezza, dove il pensiero e l’azione dei singoli sono stati sezionati, catalogati e rinchiusi in sfere staccate — lì comincia la politica. Avendo allontanato alcune attività degli individui (la discussione, il conflitto, la decisione in comune, l’accordo) in una zona a sé che pretende di governare — forte della sua indipendenza — tutte le altre, la politica è allo stesso tempo separazione tra le separazioni e gestione gerarchica della separatezza. Così essa si rivela come specialismo, costretta a trasformare il problema irrisolto della propria funzione nel presupposto necessario per risolvere tutti i problemi. Proprio per questo il ruolo dei professionisti in politica è indiscutibile — e tutto ciò che si può fare è sostituirli di tanto in tanto. Tutte le volte che i sovversivi accettano di separare i vari momenti della vita e di cambiare — partendo da questa separazione — le condizioni date, diventano i migliori alleati dell’ordine del mondo. Proprio mentre aspira ad essere una sorta di pre-condizione della vita stessa, la politica soffia ovunque il proprio alito mortifero.
La politica è l’arte della rappresentanza. Per governare le mutilazioni inflitte alla vita, essa costringe gli individui alla passività, alla contemplazione dello spettacolo allestito sulla propria impossibilità di agire, sulla delega irresponsabile delle proprie decisioni. Allora, mentre l’abdicazione alla volontà di determinare se stessi trasforma i singoli in appendici della macchina statale, la politica ricompone in una falsa unità la totalità dei frammenti. Potere e ideologia celebrano così le proprie nozze funeste. Se la rappresentanza è ciò che toglie agli individui la capacità di agire, fornendo loro come contropartita l’illusione di essere partecipanti e non spettatori, questa dimensione del politico riappare sempre là dove una qualsiasi organizzazione soppianta i singoli e un qualsiasi programma li mantiene nella passività. Riappare sempre là dove un’ideologia unisce ciò che nella vita è separato.
La politica è l’arte della mediazione. Tra la presunta totalità e i singoli, e tra individuo e individuo. Come la volontà divina ha bisogno dei propri interpreti terreni, così la Collettività ha bisogno dei propri delegati. Come nella religione non esistono rapporti tra uomini ma solo tra credenti, così nella politica a incontrarsi non sono gli individui, bensì i cittadini. I legami di appartenenza impediscono l’unione perché solo nella differenza la separazione scompare. La politica ci rende tutti uguali poiché nella schiavitù non ci sono diversità — uguaglianza davanti a Dio, uguaglianza davanti alla legge. Per questo al dialogo reale, che nega la mediazione, la politica sostituisce la sua ideologia. Il razzismo è l’appartenenza che impedisce i rapporti diretti tra i singoli. Ogni politica è simulazione partecipativa. Ogni politica è razzista. Solo demolendo nella rivolta le sue barriere si possono incontrare gli altri nella loro singolarità. Mi rivolto, dunque siamo. Ma se noi siamo, addio rivolta.
La politica è l’arte dell’impersonalità. Ogni azione è come l’istante di una scintilla che sfugge all’ordine della genericità. La politica è l’amministrazione di quell’ordine. «Cosa vuoi che sia un’azione di fronte alla complessità del mondo?» Così argomentano gli addormentati nella duplice sonnolenza di un Si che è nessuno e di un Più tardi che è mai. La burocrazia, fedele ancella della politica, è il niente amministrato affinché Nessuno possa agire. Affinché ciascuno non riconosca le proprie responsabilità nell’irresponsabilità generalizzata. Il potere non dice più che tutto è sotto controllo, dice al contrario: «non ci riesco nemmeno io a trovare i rimedi, figuriamoci qualcun altro». La politica democratica ormai si fonda sull’ideologia catastrofica dell’emergenza («o noi o il fascismo, o noi o il terrorismo, o noi o l’ignoto»). La genericità, anche quella antagonista, è sempre avvenimento che non avviene mai e che cancella tutto ciò che avviene. La politica invita tutti a partecipare allo spettacolo di questi movimenti da fermo.
La politica è l’arte del rinvio. Il suo tempo è il futuro, proprio per questo imprigiona tutti in un miserabile presente. Tutti insieme, ma domani. Chiunque dice «io e adesso» rovina, con quell’impazienza che è esuberanza di desiderio, l’ordine dell’attesa. Attesa di un obiettivo che esca dalla maledizione del particolare. Attesa di una crescita quantitativa adeguata. Attesa di risultati misurabili. Attesa della morte. La politica è il tentativo costante di trasformare l’avventura in avvenire. Ma solo se «io e adesso» decido ci può essere un noi che non sia lo spazio di una reciproca rinuncia, la menzogna che ci rende l’uno il controllore dell’altro. Chi vuole agire subito è guardato sempre con sospetto. Se non è un provocatore, si dice, di certo ne fa i servizi. Ma è l’istante di un’azione e di una gioia senza domani che ci porta al mattino dopo. Senza lo sguardo fisso alle lancette.
La politica è l’arte dell’accomodamento. Attendendo sempre che le condizioni siano mature, si finisce prima o poi con l’allearsi ai padroni dell’attesa. In fondo la ragione, che è l’organo della dilazione e del rinvio, offre sempre qualche buon motivo per accordarsi, per limitare i danni, per salvare qualche dettaglio di un tutto che si disprezza. La ragione politica ha occhi aguzzi per scovare le alleanze. Non tutto è uguale, ci dice. Rifondazione Comunista non è certo come questa destra rampante e pericolosa. (Alle elezioni non la si vota — siamo astensionisti, noi — ma i comitati cittadini, le iniziative in piazza sono un’altra cosa). La sanità pubblica è pur sempre meglio dell’assistenza privata. Un salario minimo garantito è pur sempre preferibile alla disoccupazione. La politica è il mondo del meno peggio. E rassegnandosi al male minore, si accetta passo per passo quel tutto al cui interno soltanto sono concesse le preferenze. Chi invece di questo meno peggio non ne vuole sapere è un avventuriero. O un aristocratico.
La politica è l’arte del calcolo. Affinché le alleanze siano proficue, degli alleati bisogna apprendere i segreti. Il calcolo politico è il primo segreto. Occorre sapere dove si mettono i piedi. Occorre redigere dettagliati elenchi degli sforzi e dei risultati. E a forza di misurare ciò che si ha, si finisce col guadagnare tutto, tranne la voglia di giocarselo e di perderlo. Così si è sempre presso di sé, attenti e pronti a chiedere il conto. Con l’occhio fermo su ciò che ci circonda, non ci si dimentica mai di se stessi. Vigili come i carabinieri. Quando l’amore di sé diventa eccessivo, chiede di donarsi. E questa sovrabbondanza di vita ci fa dimenticare di noi stessi, ci fa perdere, nella tensione dello slancio, il conto. Ma la dimenticanza di sé è il desiderio di un mondo in cui valga la pena perdersi, di un mondo che meriti il nostro oblio. Ed è per questo che il mondo così com’è, amministrato da carcerieri e da contabili, va distrutto — per fare spazio al dispendio di noi stessi. Qui comincia l’insurrezione. Superare il calcolo, ma non per difetto, come raccomanda quell’umanitarismo che, chiotto chiotto, alla fine si allea sempre con il boia, bensì per eccesso. Qui finisce la politica.
La politica è l’arte del controllo. Che l’attività umana non si liberi dalle pastoie dell’obbligo e del lavoro per rivelarsi in tutta la sua potenza. Che gli operai non si incontrino in quanto individui e non cessino di farsi sfruttare. Che gli studenti non decidano di distruggere le scuole per scegliere come, quando e cosa imparare. Che i famigliari non si innamorino e non smettano di essere piccoli servitori di un piccolo Stato. Che i bambini non siano qualcosa di diverso dalla copia imperfetta degli adulti. Che non si liquidi la distinzione tra (anarchici) buoni e (anarchici) cattivi. Che non siano gli individui ad avere rapporti, bensì le merci. Che non si disobbedisca all’autorità. Che se qualcuno attacca le strutture dello sfruttamento dello Stato ci si affretti a dire che «non è opera di compagni». Che le banche, i tribunali, le caserme non saltino in aria. Insomma, che la vita non si manifesti.
La politica è l’arte del ricupero. Il modo più efficace per scoraggiare ogni ribellione, ogni desiderio di cambiamento reale, è presentare un uomo di Stato come sovversivo, oppure — meglio ancora — trasformare un sovversivo in un uomo di Stato. Non tutti gli uomini di Stato sono pagati dal governo. Ci sono funzionari che non si trovano in parlamento e nemmeno nelle stanze adiacenti; anzi, frequentano i centri sociali e conoscono discretamente le principali tesi rivoluzionarie. Discettano sulle potenzialità liberatorie della tecnologia, teorizzano di sfere pubbliche non statali e di oltrepassamento del soggetto. La realtà — lo sanno bene — è sempre più complessa di qualsiasi azione. Così, se auspicano una teoria totale è solo per poterla, nella vita quotidiana, dimenticare totalmente. Il potere ha bisogno di loro perché — come loro stessi ci insegnano — quando nessuno lo critica il potere si critica da sé.
La politica è l’arte della repressione. Di chiunque non separa i vari momenti della propria vita e vuole cambiare le condizioni date a partire dalla totalità dei propri desideri. Di chiunque vuole bruciare la passività, la contemplazione e la delega. Di chiunque non si lascia soppiantare da alcuna organizzazione né immobilizzare da alcun programma. Di chiunque vuole avere rapporti diretti tra individui e fa della differenza lo spazio stesso dell’uguaglianza. Di chiunque non ha alcun noi su cui giurare. Di chiunque disturba l’ordine dell’attesa perché vuole insorgere subito, non domani o dopodomani. Di chiunque si dona senza contropartita e se ne dimentica per eccesso. Di chiunque difende i propri compagni con amore e risolutezza. Di chiunque offre ai ricuperatori una sola possibilità: quella di scomparire. Di chiunque rifiuta di prendere posto nell’innumere schiera dei furbi e degli addormentati. Di chiunque non vuole né governare né controllare. Di chiunque vuole trasformare l’avvenire in una affascinante avventura.
[Da Il pugnale, numero unico del maggio 1996]